Ecco il numero estivo di Fare Voci, con un’altra serie di proposte d’autore.
Ad iniziare dal poeta ucraino Oleksandr Irvanets, e la sua antologia “Il venditore di stelle”, per proseguire con le poesie inedite di Luigi Nacci, l’incontro con Alessandro Agostinelli che ci racconta della collana Poesia Serie Rossa delle Edizioni ETS da lui diretta, e con le poesie di Vera Lúcia de Oliveira, dalla sua nuova raccolta “Ero in un caldo paese”.
Il narrare è tutto nel bel libro “Lo chiamavano Frank” di Giorgio Mosetti, nello scritto da Bruxelles di Ilaria Battista e nel racconto “I ragazzi di primavera” di Filippo Medeot.
Le immagini sono le fotografie di Giulia Iacolutti, con il suo intenso progetto “Jannah”.
Buona lettura.
Giovanni Fierro
(la nostra mail è farevoci@gmail.com)
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Voce d’autore ————————
La coscienza va a fuoco
Oleksandr Irvanets, “Il venditore di stelle”
di Giovanni Fierro

“In gioventù scrivevo versi lirici e d’amore, poi il vino è diventato aceto e la satira ha preso il sopravvento”. Di certo questa affermazione, da una intervista di due anni fa, contiene tutto il fare poesia di Oleksandr Irvanets, poeta ucraino che possiamo conoscere grazie alla bella antologia di suoi scritti “Il venditore di stelle”, curata e tradotta da Paolo Galvagni e pubblicata da i Quaderni del Bardo nella Collana di poesia slava contemporanea.
Una raccolta di poesie che va dagli anni ottanta fino ai tempi più
recenti, per delineare lo spessore artistico e culturale di Irvanets,
attivista ed agitatore culturale nel periodo dell’Urss, e coscienza
critica nell’Ucraina contemporanea.
Il suo scrivere sa muoversi con talento fra sarcasmo e immagini, fra lettura attenta e invenzione.
Perché in questa scelta di suoi scritti emerge la forza della visione, “Pensate
sia vicino?/ Ohi, è lontana/ quella terra stupenda,/ Alla quale volano
attraverso/ I mari le cicogne non dipinte/ E i petali bianchi del
calendario…”, dell’estate 1980, che andrà poi ad alimentare la tensione che sarà l’innesco delle poesie a venire: “L’anima è piena di dubbi, come di fiamme./ La coscienza va a fuoco”.
Il suo è un quotidiano che viene rivoltato e fatto saltare in aria, alla
ricerca di nuovi punti di vista e di sensi inaspettati. Quanto
necessari.
E, come rivela nell’intervista che potete leggere di seguito, anche la
religione – ma a modo suo – è un riferimento importante, ulteriore lente
per avvicinarsi ad ogni accadere del vivere, perché “Portare la croce, dicono, è un dogma”.
I suoi occhi continuano ad essere uno sguardo acceso e severo sulla
nostra società, nel suo divenire e nel suo promettere, ben sapendo che “La falsità non è affatto menzogna./ La falsità è oggetto di compravendita”, frase di una sua poesia del 1986 mai così attuale come ora.
“Il venditore di stelle” è qui.

Dal libro:
Percepisco la poesia come professione,
Lavoro minuzioso – con la neve e con la pioggia.
Percepisco la poesia come progressione
Nella crescita e nel perfezionamento dell’anima,
Come linea della vita, tracciata sul vetro;
Sul vetro d’una finestra, non di lenti da microscopio, –
Percepisco la poesia come professione,
Ma senza che diventi professionismo!
1984
*
Qualcuno parla dei soldi,
Ma per me da ora in poi
Le foglie di un pero nero
Sono la carta più preziosa.
È facile non comprendere,
Calpestare il concime,
La più crudele al mondo
È la svalutazione dei sogni.
Autunno 1980
*
Variazione sul tema degli avvisi nel metrò di Kyїv
ad Andrij Bondar
Non amo la parola “popolo”,
Ma il nostro popolo solleva
Docilmente i lembi dei lunghi abiti,
Salendo sulla scala mobile,
E non varca la linea di demarcazione
Sugli scalini.
Il nostro popolo in generale
Non varca mai la linea di demarcazione.
Ma invano…
18 febbraio 2002
*
Ho finalmente capito qualcosa della morte.
È come quando stai nudo, aperto a tutto.
Dolorante. E per quello la luce è smorzata.
Ed è freddo.
E hai voglia di fumare…
*
Mosè in 3d
Dove andiamo, se la falce della morte
Ci accoppa?
Sotto terra, oppure nei cieli?
Google lo sa…
Da dove viene la divinità in te e in lei,
Da dove viene la bestialità?
A sua immagine e somiglianza
Google ci ha creati.
Ciascuno di quelli che vogliono cogliere
Il futuro luminoso,
Chi lo benedice per questa faccenda?
Google onnipotente!
Ogni problema, che geme e sibila,
Piatto o rotondo,
Si può mandare lì in ogni istante:
“Su, va’ da Google”!
Esso non rivela il suo volto,
Anche se lo supplichi.
Sul monitor il rovo ardente
Avvampa quieto…
21 settembre 2012

Intervista ad Oleksandr Irvanets:
Questa raccolta, “Il venditore di stelle”, è una selezione di
poesie scritte dagli anni 80 fino ai 2000. Qual è il filo rosso che le
contraddistingue?
Prima di tutto, queste poesie sono proprio tutte mie. Ho lavorato sul
limare il mio stile per tanti anni, per cui solo io e nessun altro è
responsabile per ogni verso e parola di cui sono fatte.
A proposito, la parola ‘stile’, che è la stessa anche in ucraino, in
inglese e in molte altre lingue, ha origine dalla parola ‘stylo’ che ci
fu data dagli italiani.
Leggendo questi testi ci sono due cose che ritornano spesso:
la parola ‘croce’ e la pittura. Hanno un qualcosa di speciale nel suo
fare poesia?
Penso che questa impressione sia dovuto alla scelta delle poesie fatta da Paolo Galvagni, che le ha tradotte.
Anche se da giovane mi piaceva dipingere – con la pittura avevo una
certa confidenza e ho visitato i migliori musei di Mosca, San
Pietroburgo, Vienna, Berlino, Parigi, Monaco, Roma e Firenze – la mia
poesia non può di certo essere considerata una collezione di quadri ad
olio.
Le mie poesie assomigliano di più a delle grafiche, veloci e nitide. E
le mie poesie satiriche sono proprio delle caricature ad hoc, sono il
grottesco che cattura la vita.
Come per la ‘croce’, io non sono un uomo molto religioso, ma sono cristiano seguendo le mie convinzioni.
Le Sacre Scritture sono ‘il Libro’ e il mio termine di paragone.
Contengono così tante storie e personaggi che nessun scrittore può
neanche immaginare di creare.
Ho alcuni miei versi dedicati al Natale e alla Pasqua, e anche alcuni
dedicati a San Nicola (Santa Claus). Ma non vado in chiesa regolarmente,
solo alcune volte all’anno. Però leggo la Bibbia, regolarmente.
Cos’è cambiato nell’essere un poeta ai tempi dell’Urss, e nell’esserlo ora?
Durante il periodo sovietico ai testi è stata data troppa importanza. È
bene ricordare che ad esempio durante quel periodo le fotocopiatrici
erano sotto uno stretto controllo, ed era impossibile duplicare i testi
privatamente.
L’apparato burocratico aveva paura della verità, e la censura era molto dura e rigida.
Ma una volta caduto l’Urss, si è scoperto che né i lavori dei dissidenti
e neanche quelli degli autori stranieri allora vietati, avevano
qualcosa che poteva essere pericoloso e distruttivo.
Gli scritti letterari sono diventati ciò che dovevano diventare, scritture creative e testi.
Durante l’Unione Sovietica il lettore cercava il sottotesto, le
allegorie, i doppi significati, ‘l’agenda nascosta’. Però non tutti i
testi avevano queste peculiarità…
Oggi, senza la censura (almeno formalmente), l’autore deve rendersi
consapevole dell’enorme responsabilità che ha. È necessario scrivere
bene, o non scrivere affatto. Come ha scritto Tolstoj, nei suoi diari.
Ma la poesia è differente: lirica, intima, di paesaggio o criptica, non
romanzata, satirica. Io lavoro in tutte queste direzioni, e suppongo che
i miei lavori siano piuttosto buoni.

In che modo pensa che la poesia possa avere la sua efficacia, la sua funzione, nella nostra vita quotidiana? E nella sua?
La poesia non può fare nulla, e può fare tanto, allo stesso tempo. La
poesia può fare stare meglio il lettore nel momento di una sua
tristezza, o ispirare le grandi imprese e i grandi gesti.
Ma un poeta non dovrebbe sovrastimare il suo ruolo! Basta guardare alla
circolazione dei libri di poesia – di regola le tirature sono solo di
alcune centinaia di copie, raramente di migliaia.
Quanto a me, la poesia mi ha salvato da alcuni periodi difficili della
mia vita. Ed è stata anche la poesia di altri poeti che mi ha ispirato,
dandomi soddisfazione ed aiuto, per lasciarmi alle spalle tutti gli
errori e i problemi del vivere.
In queste poesie la vita di ogni giorno si mescola anche con l’onirico, con il sogno. È solo una mia impressione?
Di sicuro il poeta dovrebbe ritrarre la bellezza, tradurre i sogni in
parole. E se questo è fatto bene, le parole possono diventare realtà. Ma
non è sempre così.
Perché poi, in questo suo scrivere, si ha l’impressione che
la realtà sia esplosa, e queste sue poesie cerchino di mettere assieme
tutti i suoi mille pezzetti… può essere (anche) così?
È così. Quando scrive poesie, il poeta cattura sia il suo proprio stato d’animo che il mondo in cui è immerso.
Per me la creatività poetica è il tentativo determinato di fermare, di
‘fotografare’ i momenti della mia vita, dei miei sentimenti, delle mie
esitazioni.
Mettere il mondo in ordine, tramite il dargli parola e con le parole, è per me il compito della poesia e di ogni poeta.
Scrive anche romanzi, racconti e testi per il teatro…
Si, scrivo prose e testi per il teatro, lavoro su differenti generi e ho scritto anche la sceneggiatura per un film.
Comunque, penso che la poesia sia la massima manifestazione della creatività.
Creare una poesia è magia, è una ascesa spirituale, è la gioia dell’ispirazione.
Posso creare poesie quando cammino in un parco o quando sono su un autobus, anche quando lavoro ad un romanzo.
Ma lavorare ad una storia o ad una sceneggiatura significa stare seduto
al tuo tavolo, in una profonda concentrazione e continuità. Questo è il
perché non mescolo mai la poesia con gli altri generi.
La poesia è il più alto e meraviglioso esercizio per l’intelletto e l’anima.

L’autore:
Oleksandr Irvanets è nato a L’viv, importante centro culturale dell’Ucraina sud-occidentale, nel 1961.
Nel 1980 si è diplomato all’Istituto Pedagogico di Dubno, nel 1989 all’Istituto Letterario di Mosca.
Dal 1993 risiede a Irpen’ nei pressi di Kiev.
Poeta, narratore drammaturgo e traduttore, ha pubblicato la sua prima poesia nel 1979.
Le sue opere teatrali sono state messe in scena in Ucraina, Germania, Austria, Polonia e Lussemburgo.
Nel 1995 ha ricevuto il Premio della Fondazione Helen Shcherban-Lapika negli Usa, e nel 2007 il premio “Lingue minoritarie” a Sassari.
(Oleksandr Irvanets “Il venditore di stelle” pp. 89, 10 euro, i Quaderni del Bardo 2018)
– un sentito ringraziamento a Stefano Donno e Paolo Galvagni per la disponibilità e l’aiuto per questo articolo ed intervista –
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Voce d’autore ———————-
Versi per la viandanza che verrà
Tre poesie inedite
di Luigi Nacci

Se tutto ti trattiene parti
Riempi di ombre lo zaino
Lascia il tuo nome sull’uscio
Entra raggiante nel giorno
Avanza come un bisonte
Riposa come una roccia
Rispetta il passo dell’ultimo
Resta in ciò che dura
*
Vai verso un punto saliente
La casa dell’amico dissolto
Lo scoglio che origina il mare
I resti dell’albero sacro
Oppure vai soltanto per andare
Fissa la meta nell’uragano
Nello scontro delle correnti
Nel bianco che anticipa la fine
Qualunque sia la ragione del viaggio
Scomparirà di fronte al gorgo
*
Ecco le cose come sono
Gli uomini nascono e muoiono
La terra ruota su se stessa
Il sole sorge e poi tramonta
Le linci non mangiano carogne
I cervi hanno i palchi non le corna
Le acque scorrono verso il mare
Eppure il mare non è mai pieno
Meglio il rimprovero del saggio
Che la lode dello stolto
Il viandante non ha difese
Camminando hai la libertà
Di non essere nessuno

L’autore:
Luigi Nacci, nato nel 1978 a Trieste, è poeta e scrittore. Ha pubblicato in poesia: “Il poema marino di Eszter” (Battello, 2005), “poema disumano” (Cierre, 2006; Galleria Michelangelo, 2006), “Inter nos/SS” (Galleria Mazzoli, 2007), “Madrigale OdeSSa” (d’if, 2008), “odeSS” (in Decimo quaderno italiano di poesia contemporanea, Marcos y Marcos, 2010).
In prosa: “Trieste allo specchio” (Battello, 2006), “Alzati e cammina” (Ediciclo, 2014), “Viandanza” (Laterza, 2016) e “Trieste selvatica” (Laterza, 2019).
Per Ediciclo dirige la collana “La biblioteca del viandante”.
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Tempo presente ————————–
Vent’anni dalla parte della poesia
Le Edizioni ETS, Poesia Serie Rossa
di Giovanni Fierro

Vent’anni dalla parte della poesia. È questo l’impegno che le Edizioni ETS si si sono prese, con un rinnovato slancio e una rinnovata fiducia nella collana Poesia Serie Rossa diretta da Alessandro Agostinelli, che ne aveva determinato la nascita, con la precedente collana Poesia.
Due decenni di ricerca e di costruzione, per dare alla poesia nome e
cognome, significato ed immaginario. Scegliendo autori, italiani e
stranieri, che con il proprio scrivere hanno dato, stanno dando, un
contributo fondamentale ad alimentare il mondo del fare poesia.
In questo nostro spazio, giunge quindi l’occasione per esplorare il
lavoro e gli autori di Edizioni ETS, assieme al curatore della collana,
Alessandro Agostinelli.
Intervista ad Alessandro Agostinelli:
Venti anni di poesia con un catalogo prestigioso: gli
italiani Carifi, Kemeny, Veracini e tu stesso, lo sloveno Brane Mozetic,
lo spagnolo Luis Garcia Montero e gli americani George Oppen e Sam
Hamill.
Ti chiedo, cosa del fare poesia di questi autori è riferimento e spunto, per i poeti della nuova Poesia Serie Rossa?
La collana Poesia Serie Rossa delle Edizioni ETS è in piena continuità
di scelta e ricerca del meglio nel campo della lirica italiana e
internazionale.
Con la precedente collana Poesia l’editore mi aveva accordato la
possibilità di pubblicare un libro e mezzo all’anno. Erano pochi. In
fondo solo tre libri ogni due anni. Così ho potuto fare un gran lavoro
di scelta, parlando dove era possibile con gli autori stessi. Sono un
editor esigente e intervengo spesso nel merito degli scritti degli
autori che scelgo di pubblicare e che mi piacciono.
Oggi abbiamo fatto un cambiamento grafico e abbiamo deciso di pubblicare
qualche titolo in più, così ho potuto allargare lo spazio in collana
per gli italiani.
La collana di poesia di ETS l’abbiamo messa in piedi nel 2000 e mi
piacerebbe proseguire ancora per altri venti anni. È un lavoro che mi
appassiona. Così posso leggere molte nuove proposte che anche se non
pubblicherò io, magari troveranno risalto presso altri editori attenti.
Diciamo che oggi si è allargato il sentiero della poesia italiana e
resta quello della poesia in lingua inglese (con traduzione italiana).
Abbiamo invece abbandonato la parte iberica.
Con i nuovi poeti che si sono aggiunti in questi anni più
recenti, come è cambiato lo ‘sguardo d’autore’ nel raccontare ed
esplorare il nostro tempo?
Per gli amanti della poesia contemporanea segnalo che abbiamo cominciato
un attraversamento dell’ignoto. Segnalo tre poeti degli ultimi due anni
di grande interesse. Uno è l’italiano Tommaso Pierini, toscano che ha
una voce molto interessante: un lirismo realista che incanta. Poi
abbiamo un volume, il primo in Italia, di Bernard Vanel, un bravo
scrittore francese di periferia, interessato al tema dei viaggi. Altro
libro da segnalare è quello del grande italoamericano Luciano Jude
Mezzetta. Il suo è il libro di una vita, una scelta (rilkiana verrebbe
da dire) del meglio della sua produzione ormai di mezzo secolo di
durata.
Che dialogo si è creato fra i vari autori, fra quelli
italiani e quelli stranieri… dialogo di sicuro non personale, ma di
certo di significati e valori esposti nelle loro pagine…
Non ci sono dialoghi incongrui tra autori che si ignorano. C’è però
soltanto una rotta editoriale: scegliere secondo la capacità fonica e di
attenzione sillabica, oltre che sui contenuti e sui colpi di scena
lessicali di autori che mostrano una consapevolezza nel loro scrivere.
Cosa significa, in termini di impegno e di obiettivi, l’essere responsabile di una collana di poesia?
È un impegno totalizzante nel senso dell’interesse verso la poesia e le
varie forme letterarie, ma ciò si iscrive nel mio modo di essere lettore
e scrittore. Alla collana dedico tutta l’attenzione possibile quando
lavoro su un libro con l’autore scelto per la pubblicazione.
Sono un editor esigente e cerco di convincere delle mie idee ogni poeta
che pubblica con ETS. Lo so che sono a volte sono un po’ troppo
esigente, ma credo serva a far crescere nuovi autori e alle poesie
stesse che andiamo a mettere dentro al libro.
Più semplice, per certi versi, è la scelta degli autori perché si vede
subito se un lavoro vale o non vale, a prescindere dalla mole di
limature e correzioni che servono per rendere un testo buono per me.

In che modo ancora oggi la poesia è necessaria? E può essere un fulcro di una certa coscienza civile, oltre che umana?
La poesia è il succo della lingua. Questo dovremmo cercare noi poeti. A
maggior ragione la responsabilità di uno scrittore come me, che sceglie
anche poesia da pubblicare, è doppia. Se la conoscenza della tradizione,
e le capacità linguistiche e versificatorie sono la base per fare un
poeta, poi sarà la sua sensibilità artistica, la sua tenacia e la
fortuna dei suoi incontri che determineranno una nuova autorevole voce e
così un perpetuarsi della necessità della poesia.
Le Edizioni ETS sono di Pisa; in che modo si confrontano con
il territorio? E in specifico con la pubblicazione di libri di poesia?
ETS è un editore conosciuto per la filosofia, la pedagogia e
pubblicazioni accademiche di livello scientifico. Ho piena libertà di
scelta sulla collana e questo è impagabile. Dopo venti anni di lavoro
assiduo, che ho alimentato anche con alcune rassegne internazionali
importanti nei primi anni 2000, la collana è conosciuta e non può essere
ignorata. Chi la ignora fa un cattivo servizio al sistema poetico
italiano e un cattivo servizio al suo sapere.
Chiaramente abbiamo molte proposte anche dal territorio toscano, oltre che da tutta Italia, ma non abbiamo un limite geografico.
Qual è il tuo giudizio sullo stato della poesia italiana attuale, e sulla sua specifica editoria?
Rispondere a questa domanda è impossibile. Servirebbe un saggio. Ne ho
discusso e scritto in tante occasioni (su blog, in interviste, su
giornali e settimanali famosi) con colleghi poeti, critici, editori. È
inutile che ripeta cose che tutti sanno già per conto loro e che non
servirebbero se non ad alimentare il già noto.
Dal catalogo:
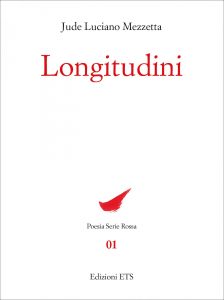
Ogni giorno
quelli che odiano
quelli che odiano la vita stanno vivendo
e quelli che amano
quelli che amano la vita stanno morendo
e quelli che vogliono
essere liberi
loro sono liberi.

Abbiamo fatto l’amore su una brandina da campo.
Che diavolo ci fa una brandina da campo
nella casa di un fotografo di moda
non è Capa, non è…

Per tutti sono Icaro che studia le rotte degli aironi. Cammino a grandi passi per non farmi raggiungere. Mi fermo solo dove il vento è più forte. Apro la mia scatola dei colori. Dipingo rami stracciati, l’aria oscurata da un improvviso temporale, l’impasto opaco del cielo.

Let the blow fall soon or late,
Let what will be o’er me;
Give the face of earth around
And the road before me.
Prendi pure il vagabondo,
qualunque cosa accada.
Dammi il volto del mondo,
e qui davanti la strada.

Con la tua tonaca nera, qualche libro sotto il
braccio, “un po’ d’aglio nelle vocali” (come si
diceva di Stendhal), sei tu che mi hai insegnato
il desiderio dell’Italia, le terre bruciate della
Basilicata e i cipressi della Toscana.

Il curatore:
Alessandro Agostinelli è nato in Maremma nel 1965 e vive a Firenze. Si è laureato in Lettere ed è dottore di ricerca in “Storia delle arti visive e dello spettacolo”.
Scrive per “L’Espresso”, Radio RAI, Radio 24 – Il Sole 24 Ore, Lonely
Planet, e ha diretto alcuni documentari di viaggio e d’inchiesta.
I suoi libri più recenti sono il romanzo “Benedetti da Parker” (2017), la raccolta poetica edita in Spagna “En el rojo de Occidente” (2014) e il diario di viaggio “Honolulu Baby” (2012).
Per Samuele Editore ha appena pubblicato il volume “L’ospite perfetta. Sonetti italiani”.
Ha curato gli spettacoli teatrali “Confessione di Natale” da Robert Louis Stevenson (2015), “Confessione alla fidanzata” da Fernando Pessoa (2016), “Confessioni di vita e di morte” da Raymond Carver (2017-2018). Dirige il Festival del Viaggio.
http://atlante.blogautore.espresso.repubblica.it/
http://www.edizioniets.com/
(il fotoritratto grande di Alessandro Agostinelli è di Marzia Stevenson Maestri)
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Tempo presente ———————-
Non è che sei proprio invisibile
Fumetti a Bruxelles
di Ilaria Battista

Ci sono muri che parlano.
Che poi le parole siano urlate, sottratte, sussurrate a colpi di pennello è solo un dettaglio.
Ci sono città i cui muri hanno molto da dire.
Bruxelles è una di queste.
Del resto è la capitale mondiale del fumetto, con orgoglio, e questo orgoglio lo mostra ovunque.
Dai marciapiedi poetici alle strisce pedonali politiche, dai cartelli
stradali che sono vignette a puntate agli avvisi covid a prova di
analfabeta.
All’inizio pensavo che fosse la vanità dei quartieri Art Decò a
parlare, poi le dichiarazioni esibite delle zone everything friendly,
poi ancora che fosse il tentativo di abbellire il quartiere centrale
ormai così decaduto che non lo risolleva neanche la ruspa gigante
disegnata per tre edifici.
Poi ho capito che è proprio il modo locale di esprimere la propria opinione.
Non so se queste storie urbane via disegno siano spontanee o
commissionate da una delle 19 battibeccanti municipalità che formano il
comune di Bruxelles.
Certi dipinti sono così particolareggiati che ci devono essere voluti giorni per trovare l’intesa tra vernice e pennello e sono così sfacciati che le numerose pattuglie che zigzagano per la città non possono non averli notati mentre erano in divenire.
E quando dipingi per tre piani il sosia di Asterix che alza un puffo
che regge una scala su cui un cane scodinzola ad una bambina che mangia
delle mele fucsia, non è che sei proprio invisibile.
Né tu né la frutta fosforescente.
E per quanto ci sia un generale senso di laissez-faire in giro, se uno
una mattina apre la finestra e sbatte la faccia su una nave pirata che
solca i mari inseguita da squali volanti, se non è d’accordo forse un
pochino si altera.
Ho pensato di cercare notizie dettagliate da fonti autorevoli.
Come è iniziato tutto questo?
C’era un sindaco fumettista tra i vari 19?
Alla municipalità di Etterbeek avanzavano pennelli e bidoni di pittura e non sapevano dove metterli?
C’era un fumettista folle che girava per la città e non si è mai fatto beccare?
Un collettivo che si passava il pennello colante tipo catena di San
Antonio per sfidare la polizia il decoro e l’ordine costituito?
Nessuno ha saputo darmi risposte precise, o meglio, le risposte erano
così varie e così dettagliate che alla fine erano tutte convincenti e
non si poteva credere a nessuna.
Ho deciso di rimanere in una poetica mia ignoranza.
Forse ha ragione quello che seduto per terra fa ritratti con i gessetti a Saint-Géry.
‘Semplicemente ci piace disegnare’.

L’autrice:
Ilaria Battista è nata e cresciuta a Gorizia. Da sempre
in cerca delle parole giuste, si è riappropriata del piacere di
scrivere frequentando i corsi di scrittura creativa dall’Unitre di
Cormons (Go).
Scrive, fotografa finestre illuminate e prova a immaginare la vita di improbabili inquilini.
Ha esposto le sue fotografie in varie mostre in Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a numerose letture pubbliche.
È da poco ritornata da Bruxelles, dove si era trasferita per fare delle ricerche in ambito giuridico.
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Voce d’autore ——————————
Tutto è luce e nulla manca
Vera Lúcia de Oliveira, “Ero in un caldo paese”
di Giovanni Fierro

L’essenza delle cose sta nella luce che producono, in
quell’irripetibile istante che diventa il proprio manifestarsi, la
propria chiamata al mondo.
Ed è questa luce il vivere del fare poesia di Vera Lúcia de Oliveira e dei suoi testi inclusi nella sua più recente raccolta “Ero in un caldo paese” (seconda classificata al concorso Faraexcelsior 2019).
Uno scrivere che già dalla sua prima pagina è un invito allo stare dentro a tutto ciò, ad ogni verità, perché “Bisogna andare a fondo/ infilare la mano con delicatezza/ nella pancia di Dio”.
È una luce mai idealizzata ma sempre capace di un tessuto umano, di cui
si ha bisogno per muoversi nel sé più profondo e sincero.
E in questo suo scrivere, Vera Lúcia de Oliveira ci ricorda di come sia
necessario che il tutto sia un fiorire continuo, per stare dentro al
momento preciso, al luogo che separa il prima e il dopo, “come se il mondo/ fosse nato/ ora”.
In questo accendersi continuo, in cui il lavoro dell’autrice è quello di
riconoscerlo e valorizzarlo, è fondamentale indicare il come la luce
sia fonte di nutrimento, “apriva la bocca/ e a sorsi e a morsi/ ingoiava la luce”; e forza, “il sole irrompe/ e ferisce la nebbia”.
Ma queste pagine, per dare ancora più significato alla luce, respirano
anche un dolore adulto, maturo e consapevole, che ne diventa la naturale
parte integrante, inscindibile e caratteriale.
Perché “nulla è nitido nel dolore/ ma tutto si vede di più”, ed
allora è un qualcosa che va accettato ed esplorato, che può rivelare
sorprese e illuminazioni, che ha una sua luminosità interna ed intima,
capace di mostrare quel qualcosa che esposto a troppa luce rimane
nell’abbaglio, e non si può né vedere e né guardare.
E di certo Vera Lúcia de Oliveira non rinuncia al raccontare di come la
vita ogni giorno si mostri in mille e più mille fragilità, che “come la pioggia/ si spezza/ su ogni cosa”, e di come c’è da stare “attenti a che le ombre/ non ci ingoiassero”. Nel passato, in questo presente, nel tempo che ha da venire.
Luce ed ombra sono quindi il continuo dialogo acceso per arrivare all’essenza, al pane e alla radice, ad Ungaretti.
Per riconoscere ogni volta, e capire meglio, che nel proprio stare al mondo “si era spinta così tanto su quella soglia di luce/ che aveva finito per rimanere/ dall’altra parte del giorno”.

Dal libro:
se è stato per il colore del vento
che sono nata, per il rumore delle
foglie accese di luce, l’aria che si
muove fra i panni bianche sui fili
la sera he sembra non scorrere
il midollo del tempo, questa vita
in estasi, questo corpo ardente
questo sguardo lucido
sul nucleo di tutto
*
guardavo il cielo vivo di luce
luce sui campi sui muri
diamanti nelle pozzanghere
lampi sui tetti che piano
foravano la sera
*
non si fa poesia sulla morte
ma se l’amore permane
oltre la morte se l’amore
rimane anche la morte
vissuta da viva
valeva la pena
*
vai in discesa con il vento dietro
arrivi in una piazza senza parapetto
l’infinito in fondo in cui ti puoi tuffare
tutto è luce e nulla manca e hai solo
il vento e il mondo lì dinnanzi e dietro
*
il mare qui è un orizzonte azzurro
di monti su monti a perdersi in fondo
nelle giornate limpide puoi vedere la mamma
dall’altra parte del mondo e se c’è luna
luminosa vedi il babbo piegato sul suo
orto d’estate che neppure da morto
ha lasciato
*
sbatti il corpo
contro la porta
spalanchi un porto
in posizione
fetale
accendi tutte le torce del lutto
spingi le orme della notte
quasi fino alla morte
poi torni
Intervista a Vera Lúcia de Oliveira
In questo libro la luce è protagonista assoluta. È forza che
crea, accadimento che fa cambiare le prospettive. Da cosa nasce questa
sua presenza così forte in queste pagine?
Ho sempre cercato la luce. I miei genitori, senza volerlo forse, hanno
intuito la mia natura intrinseca, quando hanno scelto il mio nome (“Vera
Lucia”, derivato dal latino e letteralmente “luce vera”).
Cerco una luce vera in ogni cosa, la fonte di luminosità di ognuno, che
talvolta lampeggia anche nel dolore profondo, in quelle persone speciali
e rare che trasformano tutto in dono.
Alcuni amici mi hanno rimproverata più volte per scegliere certe strade
difficili da percorrere nella mia poesia, come la solitudine, la
malattia, l’abbandono, la morte, ma ho sempre seguito una traccia
sottile di luce che le persone emanano anche nei luoghi bui.
Il libro ha anche un’altra sua specifica identità. È un
fiorire continuo (di ogni tema che affronta…), dà sempre l’dea di essere
nel momento preciso in cui ciò sta sbocciando. È forse questo un
desiderio, una necessità, di documentare il momento in sé, il presente
come istante irripetibile?
Cerco di fermare il tempo nel momento di genesi, quello appunto
“irripetibile”, perché lì c’è un’energia e una luce potentissime. Ma mi
interessa anche l’opposto, quando queste si spengono. Siamo forse, noi
umani, gli unici a capire tali momenti o a desiderare di farlo.
Ieri ho visto, in macchina con mio marito, una rondine caduta forse nel
primo fragile volo su una strada. L’abbiamo vista all’ultimo momento che
si dibatteva ed era forse già stata investita da una macchina prima di
noi.
Non ci si poteva fermare in quella strada, ma quella rondine l’ho
portata dentro di me a casa, che si dibatteva lì sola, un pezzettino di
carne che soffriva e forse non sapeva neanche cosa fosse il dolore
prima. Ho pensato che era più triste la sua morte proprio perché lei non
sapeva nominarla e capirla.
Sì, la ‘luce’, ma anche ‘pane’ e ‘radice’…. Mi sembra che in
questo scrivere ci sia il desiderio di ritornare alle cose necessarie,
una volontà di eliminare il superfluo e mantenere l’essenza di ogni
cosa. Non a caso in una poesia è citato Ungaretti… è così?
Cito Ungaretti ma anche Francesco d’Assisi e Sandro Penna, tutti poeti
dell’essenza delle cose, essenza e sintesi che si trovano anche nei loro
versi. Non è che non mi interessino le altre cose che ci circondano,
non sono un’eremita e non mi piace l’isolamento.
Ho bisogno di sentire attorno a me l’umanità che si muove, indaffarata o
meno, che lavora, studia, parla, cerca, protesta, piange… L’essenza che
cerco è quella della vita, che ogni creatura ha in sé e che la fa
muovere, emanare luce e calore, irradiare bellezza. Le creature emanano
bellezza anche quando non lo sanno.
Sono attratta come ogni persona dal bello, non il bello simulato o
falsificato, ma quello che bisogna sapere e voler vedere. Cerco il vero
di ognuno, il momento in cui ognuno si guarda e si vede come è davvero.
Pure la solitudine è una dimensione che esploro, anche in mezzo agli
altri, anche, ad esempio, in una strada affollata, perché la solitudine è
uno spazio interiore abitato da voci e parole che siamo in grado di
accogliere in noi.
Il libro non si divide in capitoli, ma le poesie si
susseguono pagina dopo pagina, quasi a mettere in scena un possibile
continuo flusso di coscienza, come se ogni poesia prepari già quella
successiva… come mai questa scelta?
È una caratteristica del mio modo di scrivere, sia in portoghese che in
italiano. Non scrivo poesie isolate, elaboro lungamente un tema,
qualcosa che mi sollecita, che mi turba.
Posso passare anche mesi senza scrive un unico verso e intanto
“rimugino” dentro pensieri e immagini. E all’inizio non so ancora in
quale lingua lo stia facendo. Solo ad un cerco punto mi diventa chiara
la lingua in cui quelle riflessioni si sono incanalate.
Poi arriva un momento in cui le parole, i versi quasi saltano fuori dal
flusso sanguigno sul foglio. E allora non mi fermo, scrivo di getto, una
dopo l’altra. Non sempre mantengo l’ordine, quando organizzo quel
materiale, ma molti testi sono pronti, elaborati a lungo dentro.
Il lavoro allora è di tagliare i testi superflui, anche se non è
difficile farlo perché è come se la mia misura fosse più o meno 50
poesie per ogni libro. Visto il processo di composizione, quasi a forma
di un unico poema, non uso titoli né maiuscole.

In questo costruire una organicità che tiene assieme tutto il
libro, tante sono le cose che si rompono e si spezzano (la crosta dei
semi, la luce stessa, la pioggia…). Come a ricordare la nostra (e del
mondo) fragilità e vulnerabilità?
Si, e a ricordare il mistero della nascita e della morte, in un
susseguirsi continuo, senza che possiamo fermare il tempo umano. E parlo
del tempo umano perché noi siamo consapevoli del suo scorrere e questo
passare ininterrotto arreca grande dolore a ognuno di noi.
Il suo passare ci porta verso la fine e non c’è persona che non soffra
al tale pensiero, almeno se è pienamente in sé. I miti, la religione, la
filosofia, la scienza e l’arte non hanno fatto altro che cercare una
spiegazione a tutto ciò, un senso a questo passare fugace verso il
nulla, senza poter accettare che si vada proprio verso il nulla.
Alla fine, però, nessuno ha certezze e decidiamo di credere a una
trascendenza se questo è per noi fondamentale, oppure di non credere a
niente, se questo non ci annienta.
Un’altra cosa che mi è molto piaciuta è il modo in cui viene
trattata ed affrontata la morte. In modo molto umano, lontano dal farla
essere qualcosa di cui avere paura. E anche il dolore, quando c’è, è un
dolore adulto, maturo e consapevole. Che addirittura diventa un qualcosa
di propositivo, e non semplicemente un qualcosa da cui scappare via… è
una lettura adeguata?
Mi fa piacere che si noti questo nel libro, ma non l’ho cercato. È
l’amore che ci riporta alla memoria i momenti vissuti e che attenua e,
talvolta, lenisce il dolore.
Devo dire che il dolore vivo e acuto, non so scriverlo e penso che
neanche sia giusto farlo, che bisogna rispettare il suo esperire nostro o
altrui, senza cercare scappatoie quando ci capita. La sofferenza non è
poetica, non è poesia, ma rielaborare questa esperienza per darle un
senso può diventare parola poetica, e ritengo che la poesia, per la sua
capacità di scavare visceralmente l’animo umano, sia il linguaggio più
addato per farlo.
Noto spesso che molti cercano di ingannarsi, di negare o di fuggire ad
ogni costo dai momenti difficili, e pure di negare il dolore degli
altri. Io non lo faccio, cerco un senso in tutto, raccolgo questi
momenti che si incidono nel tempo e negli spazi e penso che non
scompaiano mai del tutto.
Poi mi allontano, medito, porto con me quelle ferite nel corpo e
nell’anima, affino l’orecchio per cogliere le parole, ascolto il vento
che porta via quelle voci…
Il libro è narrato in prima persona. Ma ci sono anche dei
‘lui’ e delle ‘lei’ che prendono vita e che portano avanti il
raccontare. Chi sono?
Sono le voci che ascolto, persone che accolgo. Sono sempre attenta alle
molte voci attorno a me. Le persone spesso dicono cose di grande
intensità e bellezza e neppure se ne accorgono.
Per “belle” non intendo solo in senso estetico. Sono belle perché
profonde, vissute, stillate lentamente da dentro. Succede anche che
esprimano un nucleo aggrovigliato e informe di senso e sia necessario
districarlo e ordinarlo in qualche modo.
Sento che in me vivono tante persone, quelle che non sono e che potrei o
vorrei essere. E vivono pure gli animali, e le piante, le pietre, i
granelli di terra, l’aria, il vento… E talvolta tutti questi esseri
litigano e mi espellono da casa.
Ma essere fuori casa, fuori dal centro della mia identità, è anch’essa una esperienza arricchente.
Penso poi che il collante di tutte queste poesie, di questo
scrivere, sia quello di guardare e scoprire cosa c’è nella parte più
piccola di ogni cosa, di ogni persona, di ogni avvenimento, di ogni
paesaggio. Può essere così?
È così, come ho detto prima. Tutto per me è miracoloso perché unico,
anche una foglia, un fiore, una goccia di pioggia, la luce di ieri e
quella di oggi. Trovo molto triste che non si possa strappare dal flusso
del tempo ogni prezioso momento vissuto, ogni parola detta, ogni gesto
che non si ripeterà mai più, e la tenerezza, le mani che si sfiorano e
consolano, lo sguardo di mia mamma quando l’ho vista l’ultima volta e
lei mi ha salutato come se non fosse l’ultima.
Trovo così triste questo “spreco” di energia viscerale che penso che,
dall’inizio, con le parole, non ho fatto altro che cercare di rubare al
tempo e al nulla cose, animali e persone.

L’autrice:
Vera Lúcia de Oliveira è nata a Cândido Mota (São Paulo, Brasile) e vive a Perugia.
Insegna Letteratura Portoghese e Brasiliana alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Perugia.
Scrive sia in portoghese che in italiano ed è presente in riviste ed
antologie poetiche pubblicate in Brasile, Italia, Portogallo, Spagna,
Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Romania e Germania.
È stata premiata in diversi concorsi in Italia e all’estero.
Le sue raccolte poetiche più recenti sono “Vou andando sem rumor” (Editora Gazeta 2015), “Ditelo a mia madre” (Fara Editore 2017) e “Minha lingua roça o mundo” (Editora Patuà 2018).
(Vera Lúcia de Oliveira “Ero in un caldo paese” pp.82, 10 euro, Fara editore 2020)
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Ti racconto ————————-
Non so se mi spiego
Giorgio Mosetti, “Lo chiamavano Frank”
di Giovanni Fierro

Questo è un libro che si legge tutto d’un fiato. Non si riesce a staccare l’attenzione dal suo raccontare.
Dopo cinque anni di silenzio è tornato lo scrittore goriziano Giorgio Mosetti, con questo suo “Lo chiamavano Frank”.
Ed è tornato lo stesso Frank, che però adesso ha trent’anni in più; un
settantenne che bada al nipote dodicenne Leon e che si fa compagnia con
il gatto Nick.
Un terzetto ben amalgamato, con la saggezza di Frank che porta
l’attenzione alle cose necessarie, l’acutezza di Leon che lo rende
ragazzino speciale ma più vulnerabile, la sofisticatezza di Nick a
mettere la firma d’autore. Certo, ci sono anche Alice, figlia di Frank, e
sua nipote Tea, che assieme ad altri personaggi completano il quadro di
conoscenze e frequentazioni.
Tutto il libro è ambientato nel 2019, praticamente un capitolo al mese (usciti sulla rivista mensile ‘Gorizia News&Views’), con alla fine anche alcune pagina extra.
Ed è il quotidiano l’ambiente in cui i protagonisti di questo bel libro
di Giorgio Mosetti sono immersi. Con difficoltà e sogni, strategie di
sopravvivenza e fantasmi, slanci e paure.
Ogni pagina è un accadimento, dove gesto vitale e pensiero prendono vita. In una solitudine o in complicità.
Ma sempre con la netta sensazione che nonno e nipote difendano
strenuamente il diritto ad essere se stessi, di poter assaporare la
libertà di conoscersi e volersi bene fino in fondo. Nulla viene
indorato, anzi. Ogni aspetto della nostra società trova la propria voce,
anche la più gretta.
E allora pagina dopo pagina si entra in un caleidoscopio di ricordi ed
entusiasmi, malinconia e gioia. Dove il calcio come la musica, il
bullismo come la stupidità, la schiettezza come la timidezza, sono gli
aspetti di un presente dove bisogna avere le spalle larghe, per non
arrendersi.
Il lettore viene così coinvolto nella vita di ogni giorno, dove nonno e
nipote misurano il proprio stare al mondo, dove Gorizia trova anche le
sue presenze e il crescere e l’invecchiare sanno stringersi la mano.
Ogni capitolo del libro è un racconto a sé, con la propria identità e
voce, con una personalità che fa bene al narrare tutto. Che funziona con
precisione e umano calore.
“Lo chiamavano Frank” è lettura da fare. Con una ulteriore nota di
merito a Giorgio Mosetti, per la sua scrittura necessaria e ben dosata,
che sa trovare anche il silenzio e che alle parole giuste si affida con
fiducia.

dal libro:
“Se fossi un nonno come si deve, allora anziché arrabbiarmi
cercherei di guardare mio nipote con altri occhi. Magari capirei che
dietro a tutto quel sapere, nascosto in tutta quella erudizione, c’è
solo un ragazzino in difficoltà. O forse è proprio questo che non voglio
vedere. Un bambino non nasce in difficoltà. Non so se mi spiego.
Comunque bando alle ciance. Ora è tardi, la gamba comincia a farmi
male e i morti stanno per arrivare. Già, i morti. Quando arrivi alla mia
età ti ci ritrovi particolarmente circondato, e l’oscurità li fa
riemergere dalla nebbia del passato. Ma tant’è. Così è la vita, come si
suol dire. Quindi non mi resta che stapparmi una birra, andare in
terrazza, sedermi sulla mia sdraio e sorseggiarla guardando il Sabotino.
E in fondo c’è di peggio nella vita.”
*
“E ride. Ride di gusto. E mi guarda con occhi timidi che
brillano. Fino alle note finali, che rallentano, ammiccano, sospese su
una leggerezza che pareva smarrita.
Poi la canzone finisce. Leon, con il fiatone, mi guarda. Si capisce
che vorrebbe abbracciarmi, ma la sua timidezza – ed è buono e giusto
così – ha ripreso il suo posto.
“Fatti sotto, campione” gli dico. E allargo le braccia.
Lui si avvicina e ci si tuffa dentro.
Lo abbraccio, percependo le rapide oscillazioni del suo piccolo torace, sollecitato dal fiatone, ma non solo.
E mentre gli accarezzo la testa, lancio un’occhiata verso il divano.
Nick se la ronfa alla grande.
Eppure, ci potrei giurare, per un istante mi è parso di vederlo ballare.”
*
“Nonno Frank?
“Sì?”
“Posso farti una domanda?”
Distolgo lo sguardo dai filamenti d’argento che la Luna sta tracciando sulla baia di Sistiana e mi volto verso di lui.
“Dimmi campione”.
“Com’è morta la nonna Tina?”
“…”
“Scusa nonno, non volevo”.
“Tranquillo ragazzo, va tutto bene” dico tornando a scrutare il mare. “È morta dopo una lunga malattia, prima che tu nascessi”.
“Mi dispiace”.
“Ti ringrazio”.
“Deve essere stato brutto”.
“Che cosa?”.
“Quando stava male”.
Sento una fitta alla pancia.
“Io non c’ero”.
“…”
“…”
“Perché?”
“Perché ci eravamo… ci eravamo persi di vista già molti anni prima”.
“Come mai?”.
“Semplicemente non ha funzionato”.
“Non ti amava?”.
“Oh, certo che mi amava”.
“E tu?”
“Sì, ma troppo a modo mio”.
“Cosa vuol dire?”
“Che ci sono tanti modi di amare. E il mio, purtroppo, è sempre stato dei peggiori”.

Intervista a Giorgio Mosetti:
Frank è un sopravvissuto mi sembra, vista la sua saggezza… a
cosa è sopravvissuto? E cosa lo mette più alla prova adesso, nel nostro
presente e in questa società?
Frank è molto di più di un sopravvissuto, è un condannato a vita che ha
però trovato il modo di sgusciare fuori di cella di nascosto ogni notte.
Credo infatti che il suo sguardo privilegiato sul mondo nasca proprio
da questo.
Ciò che lo mette più alla prova, invece, è la presunzione di conoscenza e
la dilagante arroganza di molte persone di avere voce in capitolo su
qualsiasi argomento. Ma più di ogni altra cosa, a non andargli proprio
giù è la mancanza di obiettività e la totale incapacità di vedere le
cose da angolazioni differenti. Ti faccio un esempio recente. Quando la
Slovenia non riapriva il confine, peste e corna sul trattamento che ci
riservava. Ora che da est c’è il rischio di una nuova ondata di
epidemia, ecco che le stesse persone chiedono a tutta voce la chiusura
dei confini. Insomma, beviamoci tutti una camomilla e riflettiamoci su
prima di parlare a vanvera.
Suo nipote Leon ha un’acutezza rara, che lo rende molto
particolare… mi sembra che il suo futuro si preannunci ricco di
difficoltà, proprio in un momento dove acutezza ed ingegno non sono di
certo valori che vengono né insegnati né incoraggiati… e non è un caso
che soffra di atti di bullismo…
Infatti. Leon è il prototipo del ragazzo dotato che anziché vedersi
apprezzare per le sue qualità straordinarie viene bullizzato, e non solo
dai suoi coetanei, ahimè. Lo deridono per la sua passione per la
lettura, l’astronomia, la matematica e per la conoscenza in generale, ma
anche per la sua arguzia decisamente al di sopra della media. E anche
se credo che il disagio nei confronti di chi ha doti superiori sia
sempre esistito in quanto molto umano, sicuramente oggi stiamo messi
molto peggio di ieri. Interessi come quelli di Leon vengono visti da
molte persone – temo la maggioranza – come “roba da sfigati”, per gente
che non sa vivere. Come se saper vivere volesse dire bere lo spritz ogni
sera. Però devo dire che non mi preoccupo più di tanto per Leon. C’è
pur sempre nonno Frank.
Frank, il nipote Leon, il gatto Nick. Sono un trio ben affiatato, qual è il loro equilibrio?
Si potrebbe dire con una battuta che Nick è l’equilibrio Zen tra la “testa” di Leon e la “pancia” di Frank.
E mi sembra che si respiri anche un senso di libertà,
soprattutto in Frank e suo nipote Leon, oltre che a Nick; perché, anche
se non facilmente, riescono ad essere se stessi, o almeno difendono
questo desiderio di esserlo con tutte le proprie forze….
Assolutamente. La libertà per loro è fondamentale e sono disposti a fare
di tutto per preservarla. Soprattutto quella di essere diversi, o forse
è più corretto dire non omologati, anche pagandone il prezzo. Concetto
abusato e bellissimo di cui a parole si riempiono la bocca tutti, me
compreso, ma difficilissimo da mettere in pratica. Per fortuna ci sono
l’uno per l’altro a sostenersi nei momenti in cui vengono messi a dura
prova. E poi hanno Nick, che diamine!
Il libro sembra proprio respirare una continua atmosfera dove
protagonisti sono sia la malinconia che il sorriso. È ciò che anche
serve ai protagonisti per non soccombere?
Personalmente ho sempre trovato un enorme piacere e conforto sia nella
malinconia che nel sorriso. E credo che l’ironia migliore nasca sempre
da un animo amaro. Altrimenti è solo banale comicità, che va bene,
intendiamoci, ma non avrà mai la raffinatezza di un alimento agrodolce.
Nel racconto Le frange impercettibili, il mio preferito tra parentesi, Frank dice a Leon “Ridi di tutto, poiché, credimi, l’ironia molte volte salva la vita”. Beh, con me ha funzionato.

Il libro è stato scritto a puntate mensili sulla rivista
“Gorizia News&Views” per praticamente tutto il 2019. Ha quindi un
respiro sì da romanzo, ma anche con un ritmo da racconto. Era un
progetto già ben definito dall’inizio, o il libro si è costruito piano
piano, mese dopo mese?
Erano ormai cinque anni che non pubblicavo. Dopo “Chiamatemi Frank”
avevo cominciato a lavorare a due romanzi, ma appena mi mettevo alla
scrivania mi veniva la nausea. Mi dava proprio contro, così mollai
tutto. Poi, all’inizio del 2019 Vincenzo Compagnone, che dirige la
rivista, mi chiese se mi andasse di scrivere un racconto ogni mese.
Nella mia scarsa autostima il primo pensiero fu: Oddio, sarò ancora
capace di scrivere? Ma poi mi parve un’opportunità molto stuzzicante,
visto anche il format, che oltre ad essere molto meno impegnativo del
romanzo mi consentiva di tornare proprio là da dov’ero partito più di
quindici anni prima, ossia al racconto. Così accettai. E devo dire che
sono proprio contento dell’occasione che mi ha dato Vincenzo, perché mi
ha fatto tornare la voglia di scrivere. Tornando alla tua domanda, no,
il progetto non era affatto definito, come del resto non lo sono mai
stati neanche i miei lavori precedenti. Io solitamente navigo a vista.
Parto da un’idea, anche solo un’immagine, e da lì mi muovo alla ricerca
di stimoli, senza mai sapere dove andrò a finire.
E il 2019, che anno è stato? Guardandolo dal punto di vista dello scrittore…
Personalmente, il 2019 è stato quello del ritorno alla scrittura, quindi
già questo lo rende per me un anno speciale. Ma è stato un anno di
svolta anche nella mia vita privata e professionale, e forse il
riconquistato piacere della scrittura è connesso anche a questo. Per il
resto, la mia Juve ha vinto lo scudetto e perso la Champions, quindi
tutto nella norma.
Nel tuo penultimo libro di sei anni fa, Frank aveva una
quarantina di anni. Ora è un settantenne. Cosa è cambiato in lui, in
questo lasso di tempo? e cosa ti ha tenuto lontano dal pubblicare prima
un tuo altro lavoro?
Premesso che il Frank di oggi è lo stesso cane sciolto di allora,
trent’anni di vita lo hanno senza dubbio ammorbidito. Ovviamente
continua ad essere incazzato con il mondo, o meglio con l’ottusità del
mondo, ma è sicuramente più tollerante di quando aveva quarant’anni. E
ciò è dovuto soprattutto alla presenza di Leon nella sua vita.
A tenermi lontano dal pubblicare, invece, come accennavo prima, era una
perenne sensazione di malessere. Pur avendo le idee, l’atto stesso di
scrivere mi procurava disagio anziché piacere. Ed era un peccato, perché
uno dei due romanzi ai quali stavo lavorando mi piaceva molto, e
parlava proprio di Frank settantenne che andava a fare il Cammino di
Santiago con la figlia di una sua amica morta. Tant’è che proprio da lì
ho preso lo spunto per i personaggi dei racconti, sostituendo la ragazza
con il nipote dodicenne geniale, altro mio personaggio di un romanzo
iniziato e mai portato a termine.
Ora però di una cosa sono certo, devo riempire quei trent’anni di vita
di Frank. Già all’inizio di quest’anno, nel racconto di febbraio se non
ricordo male, scrissi un dialogo, dialogo realmente avvenuto tra me e
Cristina, la mia compagna, nel quale lei mi chiedeva chi fosse il padre
di Leon, e che avrei potuto scrivere di lui. Così nacque l’idea di
impostare i racconti di quest’anno sul passato e sulla famiglia di
Frank. Ma poi è arrivato il Corona virus, e Frank non poteva certo
lasciarselo scappare. Quindi è tutto rimandato a qualche romanzo futuro.
Anche la musica è protagonista nel libro (Supertramp, B.B.
King…), che importanza ha? E quale è la sua funzione anche nel momento
della scrittura?
La musica apre porte che nessuna altra forma di comunicazione, compresa
la scrittura, potrà mai aprire. Ha un canale diretto con la sfera delle
emozioni che bypassa tutto, e il flusso che si genera non lo puoi
fermare in alcun modo. Il più delle volte, quando scrivo ho bisogno di
silenzio assoluto, ma poi ci sono dei momenti in cui il mio scrivere
diventa una vera e proprio emanazione del mio mondo interiore, così
intensa e prorompente che vorrei avere dieci mani pur di starle al
passo, e in quei momenti la musica la vado proprio a cercare allo scopo
di alimentare e conservare quello stato di grazia fino all’ultima
parola. Ad esempio, proprio mentre stavo scrivendo il racconto sul
bullismo, alla radio hanno dato ‘Child of Vision’ dei Supertramp.
È stato un momento magnifico. Improvvisamente ho visto nonno Frank
strappare i disegni dei bulletti al ritmo della canzone e scimmiottare
Roger Hodgson battendo sul tavolo tasti immaginari. Non mi crederai, ma
ho dovuto mandare in loop la canzone almeno una ventina di volte, fino a
quando non ho finito il racconto. E ancora adesso, se lo rileggo, non
posso fare a meno di metterla su a tutto volume. Mi sembra
imprescindibile.

L’autore:
Giorgio Mosetti è nato nel 1966 a Gorizia, dove vive.
Ha esordito con il racconto “L’appuntamento”, con il quale ha vinto il terzo premio al Concorso “Fonopoli – Parole in movimento” 2001-2002; il racconto è stato poi incluso nella raccolta di racconti “L’uomo di argilla”.
Ha poi pubblicato i romanzi “La panchina sotto il pino”, “Nonostante me”, “Dove tutto finirà”, “E se” e “Chiamatemi Frank”, tutti editi da La Caravella editrice.
(Giorgio Mosetti “Lo chiamavano Frank” pp. 111, 12 euro, La Caravella 2019)
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Tempo presente ———————-
I ragazzi di primavera
Un racconto
di Filippo Medeot

I ragazzi di primavera escono di casa a fumarsi le sizze in cima ai colli, nuotano i pendii e i declivi con piede scanzonato e segnano il passaggio vestendo i pruni di liquido seminale. I ragazzi di primavera occupano le case abbandonate, occultate tra le frasche, e ne espropriano i divani, ammantando di mozziconi la merda dei colombi. I ragazzi di primavera si insultano e con la mano nettano il naso dal muco e guardano questa terra scavata di pampini e gazzeladre e sovrastano con occhi fieri i loro possedimenti. I ragazzi di primavera si premono il buco del culo in doccia senza dirlo a nessuno e amano le sorelle degli amici e conquistano le panchine a suon di sputi, travalicandone le mura con un balzo solo. I ragazzi di primavera sfidano le serpi sui ciottoli, lanciano petardi nei pozzi dei chiostri, dieci euro per un grammo di fumo attanagliati dalle violeciocche unico investimento sensato. I ragazzi di primavera sboccano alle fiere di paese barattando venti birre per uno scontrino e otto ore di sonno per una poppata appoggiati al muro.
I ragazzi di primavera si baciano il glande a vicenda con labbra morbide e si riempiono la faccia di botte e il loro stomaco deflagra sempre in una notte di fine estate. I ragazzi di primavera sporcano i muri dei palazzi cinquecenteschi e cagano sulla Cappella Sistina e poi piangono infreddoliti nei letti degli altri, scavandosi i polsi a morsi. I ragazzi di primavera rotolano giù dalle balle di fieno e si riempiono la bocca di parolacce e fiche e risa sguaiate e si innamorano sempre e solo a metà settimana. I ragazzi di primavera spaccano i cellulari nelle canalette di scolo e pisciano circondati dal biancospino e trasformano le bottiglie in acceleratori di particelle. I ragazzi di primavera sono temerari, si misurano il cazzo con il righello e svuotano gli autogrill della A1 con superbia di corsaro, le notti di plenilunio affogano la testa nelle fauci del soundsystem; i ragazzi di primavera insultano le guardie e non ricordano mai la pace di Westfalia annus domini 1648. I ragazzi di primavera li vedo scalare i lampioni e tuffarsi da scogli sempre troppo alti e fiorire i prati di bestemmie. I ragazzi di primavera si guadagnano la mia invidia senza alcuno sforzo, ma di quest’invidia io non so che farmene e me ne trastullo con le dita.
Questa gioia effimera, impastata nell’apice di un orgasmo, io non la so trascrivere, non la so pronunciare, e allora cosa me ne faccio di settecentocinquantasette culi aperti su chrome? Non ci è rimasto nulla se non il ventre comodo e questi ottantasette anni di vita che non sappiamo come riempire, di cui non troviamo l’etimologia, né definizione sul dizionario che ci soddisfi. Cosa fare di questo benessere, quando per strada tutti hanno la faccia impaurita, rotta di incubi, e ognuno lotta con le proprie costole? Non ci è rimasto null’altro che questa selvatichezza bruciata, incagliata tra i rovi, nei nidi dei merli, nelle taverne umide, così preziosa e volgare, Gesù al Tempio strappa la barba ai Dottori della Legge e riga loro la macchina, Luciano Lama crocifisso sul Golgota anno zero 1977 e pace per tutti. Questa selvatichezza arsa dal sole a volte sembra scomparire, dipartire infine da questo moto circolare di secoli e secoli e secoli e lasciare tutti orfani di Dio, appesi come lepri ai cavi atlantici e i corvi pazienti attorno alla forca. E poi un giorno eccola lì, sull’orlo del kaddish apparire nella nebbia dei cantieri con le cosce insanguinate e i capelli salmastri ritornare tutto il tuo decoro con la forza di uno sputo.

L’autore:
Filippo Medeot studia italianistica presso l’Università degli Studi di Udine.
Nel 2018 e nel 2019 partecipa al corso di scrittura creativa “La prima parola”, presso la galleria d’arte Prologo, a Gorizia.
Sempre nel 2019 fonda insieme agli amici di sempre il Circolo ARCI Skianto!, con lo scopo di animare la vita culturale locale e promuovere la partecipazione giovanile.
Suoi scritti sono pubblicati sulla newsletter Fantastico!
Vive a Farra d’Isonzo (Go).
Immagini ————————
Jannah
Otto fotografie
di Giulia Iacolutti

Le foto di Giulia Iacolutti qui presentate, fanno parte del suo progetto “Jannah”.
Progetto con il quale l’artista ha documentato la storia di un gruppo di
Musulmani Sufi Murabitun di Granada che nel 1995 arrivò in Chiapas,
stato di prevalenza indigena del Sud del Messico, conosciuto per la
presenza dell’Esercito Zapatista (EZLN).
Qui iniziarono a diffondere i principi dell’Islam. “Jannah” (in arabo
“Giardino”, concetto islamico del paradiso) racconta la quotidianità di
una piccola comunità che vive in una riserva naturale vicino alla città
di San Cristóbal, che cerca di far convivere le tradizioni indigene con
le ideologie esterne, costruendo così il loro personale paradiso.
Intervista a Giulia Iacolutti:
Cosa ha significato condividere così tanto tempo con la
comunità che racconti in Jannah? E cosa rimane adesso di questa
esperienza?
Mi sono sempre ritenuta una privilegiata, grazie al mio lavoro riesco a
venire a contatto con storie e persone che apportano alla mia crescita
nuove riflessioni, scoprendo modelli di vita alternativi che mettono in
discussione il mio, per non smettere mai di imparare e migliorare.
Le donne musulmane mi hanno insegnato a confidare nel mio lavoro,
paragonavano infatti la mia determinazione alla loro fede, sentimenti
che in qualche modo ci spingono a perseguire un nostro credo personale,
che si chiami Allah o Arte. Questo è quello che resta allora, un
insegnamento che vorrei trasmettere a mia figlia, oltre alla stima verso
delle persone che difendono e perseguono un’identità, a prescindere
dall’ambiente in cui vivono.
A livello professionale rimane invece un raccoglitore pieno di negativi
che illustrano una comunità indigena del Chiapas, convertitasi negli
anni ’90 all’Islam. Spero un giorno di poter pubblicare un libro che non
abbia un taglio giornalistico, bensì concettuale, che possa viaggiare e
raccontare questa storia con un linguaggio senza tempo, come mi auguro
possano essere lette le mie fotografie, sospese tra realtà e archetipo.
E cosa ti ha spinta a questa esperienza, artistica e umana?
Ritengo lo stereotipo un’arma pericolosa: con il suo potere simbolico
rischia di produrre realtà che riducono chi ne è oggetto ad aspetti
limitati, senza considerarne la complessità. Banalizzare l’identità,
anche per scopi di propaganda politica, può straformare lo stereotipo in
ideologia, fomentando razzismo e xenofobia.
La comunicazione di massa presenta spesso l’Islam in base a stereotipi,
dimentica di passare attraverso una conoscenza teologica, giuridica e
filosofica che evidenzierebbe la natura e la complessità della
religione. Luoghi comuni come l’associazione dell’Islam all’Isis e alla
sottomissione della donna all’uomo, o al dominio politico e alla
violenza, portano una/un fedele a dover spesso giustificare un credo
percepito come sospetto.
Questa avversità allo stereotipo mi ha spinta a conoscere la comunità
musulmana messicana, prima a Città del Messico, poi a San Cristobal de
las Casas, in Chiapas: desideravo raccontare una comunità convertitasi
per scelta, che vive in armonia con la società circostante di marcato
stampo cattolico, lontana da quelle che potrebbero essere definite
influenze provenienti dal “demonizzato” Medio Oriente.
La ricerca è partita quindi da domande, non da accuse, e da una volontà
di dare visibilità a una minoranza che ritengo esempio maestro di lotta
di resistenza identitaria, focus generale della mia investigazione
artistico-fotografica.
A pensare a questa comunità così isolata, si respira una
sorta di solitudine, inevitabile…. È così? Oppure è solo una mia
impressione?
Non è così. La comunità vive sui pendii di un’altura sita a pochi
chilometri da San Cristobal de las Casas, cittadina dello stato del
Chiapas, con più di 180mila abitanti. Sia gli uomini che le donne spesso
scendono in città per lavorare, per le compere o per visitare la
famiglia d’origine.
La comunità vive circondata da persone di fede non musulmana con cui
condivide la quotidianità, come la scuola, e i momenti di festa: ho
avuto la fortuna di partecipare al Eid Al Adha, la festa del sacrificio,
dove gli animali immolati sono stati preparati e offerti anche ai
vicini non musulmani, pranzando tutte e tutti seduti attorno allo stesso
lungo tavolo.
Probabilmente si può confondere con una sensazione di isolamento quello
che è il sentimento mite e dignitoso che ho cercato in ogni scatto.
Nei tuoi scatti, quindi, cos’è che questa avventura ha mosso e nutrito il tuo sguardo?
La ricerca di un equilibrio visivo che evocasse un’armonia del vivere.
Quale è la forza di queste persone, nel perseguire quello che sembra un sogno, un desiderio di comunità e fede religiosa?
La forza credo stia nella capacità che hanno di fondere l’identità
scelta con l’antica discendenza maya. Sono mossi da un grande rispetto
verso il “diverso” e sono consapevoli di come gli usi e costumi
originari non debbano essere sostituiti dai precetti islamici, bensì
integrati.
Alcune famiglie d’origine non si sono convertite all’Islam, eppure
questo non ha portato a una scissione, ma ha accresciuto un senso di
tolleranza e capacità di dialogo. La comunità ha mantenuto gli abiti
tradizionali, caratterizzati da ricami e dall’uso di pellicce di pecora;
hanno continuato a parlare in tzotzil, loro lingua madre, e non hanno
sostituito il mais con il frumento, come gli era stato chiesto dalla
comunità spagnola murabitun giunta negli anni ’90 in Chiapas, motore
iniziale della conversione.
Che accoglienza hai ricevuto, e come e in cosa si è trasformata nel tempo?
Sono stata introdotta alla comunità dall’Imam di Città del Messico, con
il quale avevo già stretto una relazione di fiducia lungo un anno di
frequentazione al Centro Educativo della Comunità Musulmana della
capitale, dove avevo sviluppato un altro progetto fotografico. Questo ha
permesso un primo incontro meno refrattario, prendendomi il tempo e lo
spazio per raccontare le mie intenzioni, ma soprattutto entrando in
confidenza con le donne della comunità che sono state le vere guide. Per
dieci giorni sono andata a trovarle, tenendo loro i bambini mentre
cucinavano, accompagnandole in moschea, insegnando loro qualche parola
di italiano e mostrando da dove venivo.
Alla fine dei dieci giorni una signora che parlava a stento lo spagnolo,
aveva calcolato impaziente quanti mesi mancassero al mio ritorno,
regalandomi una camicia ricamata e un bracciale per mia mamma; da quel
momento iniziò uno scambio di regali tra le due mamme divise da un
oceano. In totale sono andate cinque volte, ad ogni festività tra il
2016 e il 2017 ero presente, ma essendo persone di natura cauta, ad ogni
ritrovo avevo bisogno di un paio di giorni per recuperare il credito,
ad esempio regalando loro le stampe delle fotografie scattate la volta
precedente, un gesto atteso e necessario.
La dimostrazione massima la ottenni durante una cerimonia, quando l’Imam
proibì a una giornalista di fede musulmana di scattare delle foto, e,
al sentirsi chiedere perché una non musulmana fosse in moschea con una
macchina fotografica, lui rispose: “Perché lei è parte della comunità”.
Qual è il quotidiano che questa comunità vive?
Sono uomini e donne che come tutti vivono una vita fatta di lavoro,
collettività e famiglia. Da praticanti, la loro quotidianità è scandita
dal salat, la preghiera canonica, adempiuta regolarmente almeno tre volte al giorno.
E il futuro che sta aspettando questi uomini e donne, questi bambini ed anziani?
Credo che ognuno abbia la propria storia personale, non posso
prospettare un futuro per una comunità con la quale non convivo.
L’importante del mio lavoro è porre domande, non provengo dal
giornalismo, dall’inchiesta, piuttosto cerco storie di uomini e donne
che possano contenere in sé un ragionamento più ampio e universale, da
tradurre in immagine, libro, mostra o installazione, senza avere
l’immodestia di dare risposte su qualcosa o qualcuno che non sono io.
La natura mi sembra che giochi un ruolo importante in questa comunità….
Diversamente da quanto si possa pensare, non è radicato in loro un
pensiero ambientalista, piuttosto tendono allo sfruttamento delle
risorse naturali. La natura è fonte di vita, coltivano campi di mais e
usano l’acqua del ruscello, ma non si fanno scrupoli ad abbattere boschi
per costruire nuove case lungo i pendii di quella che per legge
dovrebbe essere una riserva naturale, provocando magari delle piccole
frane. Non vi è neanche una responsabilità collettiva verso la gestione
dei rifiuti, la plastica è la materia più usata. L’errore è di pensare
che queste persone, con un livello scolastico quasi nullo, possano avere
una coscienza ecologista innata, solo perché vivono in mezzo alla
natura, quando noi “occidentali” siamo l’esempio di come per sviluppare
tale consapevolezza sia necessaria un’educazione esterna, a volte
imposta.
Nel progetto fotografico, l’associazione con immagini di vegetazione non
racconta allora una vita simbiotica tra essere umano e natura, bensì,
essendo Jannah la parola araba che indica il giardino
dell’Eden, l’accostamento ricorda come si possa trovare il proprio
paradiso ovunque, anche nel sincretismo.

l’artista:
Giulia Iacolutti (1985) studia Economia dell’Arte
presso la Ca’ Foscari di Venezia e fotografia e video presso l’Accademia
del Teatro alla Scala di Milano.
Nel 2014 vince un bando europeo e si trasferisce in Messico e si diploma in Foto Narrativa alla Fondazione Pedro Meyer.
Artista visuale e documentarista, impegnata nella ricerca sulla
narrativa, utilizza differenti linguaggi per esplorare temi di natura
socio-politica in relazione alle lotte di resistenza identitaria.
Ha esposto in Messico, Colombia, USA, Spagna, Argentina, Italia e ha
pubblicato su testate nazionali e internazionali. Nel 2016-2018 è
nominata al Joop Swart Masterclass, al 6×6 Talent Program del World Press Photo e al Foam Paul Huf Award.
Nel 2019 pubblica il suo primo libro “Casa Azul”, edito da studiofaganel e da The(M) éditions (Francia), con il quale ha vinto il “Premio Marco Bastianelli”, nella sezione libro d’artista.
(un grazie a studiofaganel per la preziosa collaborazione)
rivista Fare Voci
curata da Giovanni Fierro
collaboratori:
Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Vieri Peroncini, Livio Caruso, Guido Cupani, Antonello Bifulco.




